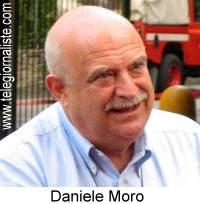 Telegiornaliste
anno II N. 11 (43) del 20 marzo 2006 Telegiornaliste
anno II N. 11 (43) del 20 marzo 2006
Moro, giornalista per vocazione
di Filippo Bisleri
Abbiamo incontrato Daniele Moro,
volto noto del Tg5
fin dai tempi dell’intervento della
Nato
nei Balcani, per raccogliere, in un’intervista, la sua esperienza
professionale.
Come hai scelto di fare il giornalista?
«Credo di essermi accorto di voler fare il giornalista quando ero
veramente molto giovane, tra la fine delle scuole elementari e l'inizio
delle medie: sono cresciuto in una famiglia nella quale si leggeva molto e
si scambiavano opinioni veramente differenti. Lo stimolo a capire era
proprio molto forte. Venivamo dalla seconda guerra mondiale, che ha segnato,
in casa nostra, i destini di molti, da chi è finito a
Dachau
poco più che bambino, a chi è andato al fronte con uno schioppo e ben
poche idee. E noi, cuccioli del dopo-guerra, a fare i conti tra i
racconti dei sopravvissuti che non erano attori del cinema, ma i nostri
genitori, zii e nonni».
Cosa ti piace di più della professione giornalistica?
«La cosa più eccitante è vedere il mondo che cambia sotto i miei
occhi, senza intermediazioni: la più frustrante è non poterlo quasi mai
cambiare».
Quali sono gli argomenti che preferisci affrontare?
«I conflitti, il dolore dei bambini, dei più indifesi: credo di saperli
mostrare senza offenderli».
Hai una preferenza per il giornalismo televisivo o ti piacciono anche
altri media come la carta stampata o le radio?
«Il giornalismo è come la musica: ce ne sono di tanti tipi e
ognuno è affascinante ed offre qualcosa che altri non ti danno».
Nella tua esperienza professionale hai un servizio, un personaggio o
un'intervista che più ricordi?
«I personaggi che mi ricorderò sempre sono quelli che soffrivano davanti
a me: come Pierre Seel, deportato dai nazisti perchè omosessuale, al
quale le SS hanno fatto mangiare dai cani il suo compagno, davanti ai suoi
occhi. Ci ha impiegato più di sei ore a raccontarmi una storia che in tv
durava otto minuti. O i bimbi di un campo profughi in Corno d'Africa,
che riuscivano a cantare con me avendo perso tutto, meno la voglia di
vivere».
Chi sono stati i tuoi maestri di giornalismo?
«Uno dei miei maestri è stato Beppe Venosta, uno dei migliori
giornalisti italiani(Panorama,
Il Mondo,
Il Sole 24ore): severo, ironico, coraggioso e molto molto paziente
anche con me. Uno che il giorno del matrimonio di Lady Diana scrisse
una pagina intera sul quotidiano di Confindustria raccontando i riti, spesso
assolutamente ignoti a noi, dello sposalizio di due sconosciuti figli della
classe operaia inglese con le sue manie e le sue follie. E in un post
scriptum ricordare che: "Lady Diana Spencer, oggi, ecc”: se fosse nato a
Londra gli avrebbero fatto un monumento. Al suo funerale, a Milano,
eravamo in sei».
Tra colleghi e colleghe chi apprezzi di più?
«Non c'è una graduatoria: apprezzo chi ne sa più di me e più in fretta.
Ce ne sono molti».
Molti sono i giovani che vorrebbero fare i giornalisti. Quali
consigli daresti loro?
«Vedo che tanti miei colleghi sconsigliano questa professione: male. Il
giornalismo rimane un sogno e neppure tanto irrealizzabile».
|
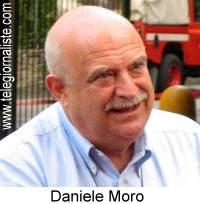 Telegiornaliste
anno II N. 11 (43) del 20 marzo 2006
Telegiornaliste
anno II N. 11 (43) del 20 marzo 2006



