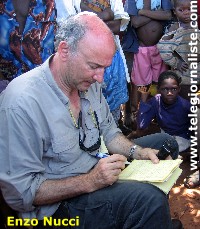Telegiornaliste
anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008
L’Africa di Enzo Nucci
di
Erica Savazzi
«L’Africa affascina perché è il Regno del
Possibile. Qui a volte ancora sogno e realtà si
confondono, i confini diventano labili tra il
racconto e il vissuto. Convivono tutto il bene e
il male del mondo, una inaudita violenza - che
porta alla costituzione di eserciti di bambini
soldato ferocissimi - si sposa a una solidarietà
estrema. In alcuni paesi non esistono gli orfani
perché i piccoli sono adottati dalla comunità. E
poi, nonostante tutto resta un territorio
totalmente inesplorato, ancora da raccontare. In
Italia poi lo ignoriamo».
Enzo Nucci
invece l’Africa la conosce benissimo.
Corrispondente Rai da Nairobi per tutto il
continente, lo vediamo alla prese con reportage
e servizi da zone di guerra come il Darfur.
Nessuno potrebbe sospettare che all’inizio della
carriera giornalistica fosse invece il cinema a
interessarlo:
«Il cinema è stato il mio grande sogno, la mia
passione infantile. Per un periodo - anche lungo
e felice della mia vita - sono riuscito a
trasformare quello che era un piacere puro in un
lavoro ricco di soddisfazioni. Ma poi ho capito
che la vita era altrove. La vita andava oltre la
celluloide o le pagine dei libri. La vita,
l’avventura era nella strada, sotto casa, nelle
persone che puoi incontrare in autobus. Ho
capito che rischiavo di rimanere soffocato nella
sala buia dove si proiettavano i film,
prigioniero di sogni e, da un punto di vista
strettamente professionale, molto emarginato,
chiuso in un limbo giornalistico spesso dominato
da signori della sala buia maldisposti a cedere
il posto ai nuovi arrivati. E così ho scelto di
fare un bagno nella cronaca nera nella mia
città, Napoli.
Un passaggio impegnativo.
«La fine degli anni 70 e l’inizio degli 80
segnano il passaggio dalla camorra impegnata
nelle tradizionali attività del malaffare
(droga, prostituzione, gioco d’azzardo, usura,
etc.) a una camorra in grado di controllare
settori dello Stato e delle istituzioni, di
influire sulla vita quotidiana di una intera
città. La cronaca nera che ho conosciuto era
appassionante proprio per questo, perché già da
allora si capiva il salto di qualità che si
preparava a fare. È stata una grande scuola
professionale, fatta di maniacale precisione,
attenzione ai dettagli all’apparenza
insignificanti, capacità di ragionamento e di
mettere insieme pezzi all’apparenza distanti.
Ricordo che proprio a Napoli, in quegli anni, fu
siglato lo scellerato patto tra malavita e
Brigate Rosse che portò a sequestri ed omicidi
ancora non chiariti a quasi 30 anni di distanza.
Insomma, formidabili quegli anni…».
Sul sito
Articolo 21 hai parlato dell’impossibilità di
fare il giornalista in Darfur a causa di
interventi governativi. Come agisce un inviato
in questi casi?
«Sono stato espulso dal Darfur senza spiegazioni
solo perché mi trovavo nella zona del campo
profughi di Kalma dove sono state uccise 46
persone e altre 200 ferite. Non mi è stato
possibile fare il mio lavoro dopo che mi erano
stati accordati tutti i permessi. In questo
caso, un giornalista non può che continuare a
denunciare quanto è successo, cercando di far
capire che dietro una macroscopica censura si
nasconde il tentativo del governo centrale di
celare le condizioni di vita in cui versano i
rifugiati e la popolazione locale. Per quanto
riguarda il Darfur, la questione è molto
complessa: non ci sono confini tra buoni e
cattivi, anche lì operano signori della guerra
interessati a mantenere incandescente la
situazione per continuare ad arricchirsi».
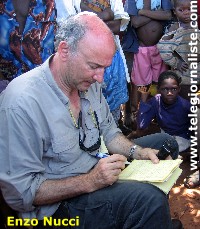 Sudan,
Somalia, Etiopia, Eritrea, Nigeria: l’Africa è
martoriata da conflitti e pare non riuscire a
uscirne. Qual è secondo te il ruolo del
giornalismo in questi contesti?
Sudan,
Somalia, Etiopia, Eritrea, Nigeria: l’Africa è
martoriata da conflitti e pare non riuscire a
uscirne. Qual è secondo te il ruolo del
giornalismo in questi contesti?
«L’Africa sconta il fatto di non avere una classe
dirigente in grado di governare un continente
potenzialmente ricco di materie prime,
autosufficiente dal punto di vista alimentare,
con un mare di intelligenze non utilizzate. La
fase di decolonizzazione è stata troppo veloce,
improvvisa, caotica e il continente per troppi
anni è stato lo scenario in cui le superpotenze
- Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina - si sono
scontrate indirettamente appoggiando le diverse
fazioni in lotta. Anche Nelson Mandela non è
riuscito ad individuare un gruppo dirigente
capace di guidare il Sudafrica che oggi vive una
profonda crisi. Il giornalismo occidentale ha il
compito di illuminare queste realtà, tenere
accesa la luce perché il destino del mondo non
dipende solo dall’elezione di Obama alla Casa
Bianca. Far conoscere queste realtà dove ci sono
anche tante cose positive che in occidente si
ignorano, come tantissimi stilisti, registi
cinematografici, scrittori, pittori che non
hanno nulla di meno dei loro colleghi europei,
statunitensi. Bene, cominciamo ad incontrali e
conoscere: hanno tanto da dire».
L’Africa – soprattutto quella non mediterranea
- è un "continente dimenticato": se ne parla
solo in occasione di conflitti. Eppure è anche
un continente su cui si concentrano le
attenzioni di molte potenze – basti pensare alla
Cina in Sudan – per non parlare poi
dell’interesse per le risorse naturali, petrolio
in primis. Come spieghi questa ambivalenza?
«Le memorie dei nostri computer e i nostri
telefonini funzionano solo grazie ai materiali
che si estraggono in Africa. Le industrie cinesi
vanno avanti grazie al petrolio africano.
Diamanti, oro e altri materiali preziosi che
vedete nelle vetrine newyorkesi vengono da qui.
Eppure si parla di Africa solo per ricordare
quanti soffrono la fame - e sono ovviamente
tantissimi - le guerre... Al massimo siamo
disposti, quando siamo benevoli, a soffermarci
sugli aspetti esotici, il ritmo che hanno
innato, una serie di inutili banalità. È un
continente che ispira tutto questo perché
convivono cose diverse e opposte ma dobbiamo
anche cominciare a pensare che ci sono tante
differenze. Pensate che in Africa ci sono almeno
2500 etnie, un numero pari di lingue e stati
spesso costruiti dagli europei con il tratto di
una matita, annullando tutte le differenze.
Cominciamo a capire la diversità e la
complessità, altrimenti non capire mai nulla.
Come occidentali dovremmo innanzitutto prendere
coscienza di non conoscere».
Preparare dei reportage è molto impegnativo.
«Preparare un reportage richiede tempo.
Innanzitutto documentazione. Internet è
importante, ma non è la chiave di volta perché
la Rete non è il Vangelo. Quindi è necessario
leggere libri, documenti delle organizzazioni
internazionali che spesso non sono reperibili in
rete. È necessario individuare gruppi, singoli
che operano e conoscono il territorio per
ricevere da loro suggerimenti, idee. Chi opera
sul campo è più aggiornato delle notizie che hai
sulle rete che spesso sono fallaci. L’esperienza
diretta in posti difficili conta più di tutto. E
poi notizie sul clima che troverai, necessità di
vaccinazioni particolari, di oggetti da portarsi
che sono magari di uso comune in Kenya, ma
impossibili da trovare in loco».
Spesso chiediamo alle telegiornaliste se hanno
problemi a conciliare vita privata e lavoro.
Data anche la tua lontananza dall’Italia, ti sei
mai dovuto confrontare con questo problema?
«Conciliare vita privata e lavoro è
difficilissimo. Si paga un prezzo alto. Una
volta si diceva che le mogli dei giornalisti
erano le vedove bianche perché con i mariti in
giro per il mondo c’era poco da stare allegre.
Ovvio che ognuno ha storie e rapporti diversi
alle spalle, capacità di tolleranza casalinga
che variano. Sicuramente questo lavoro impone
delle rinunce nella vita privata, al di là della
retorica. Il prezzo della tua lontananza da casa
lo paghi, sempre e comunque. Un bel servizio
spesso ti lascia l’amaro in bocca per una
situazione privata. Insomma, conciliare
famiglia, affetti e il lavoro di giornalista su
campo - che ti impone assenze da casa e dagli
affetti - è una bella sfida. I fortunati si
facciano avanti».
 Telegiornaliste
anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008
Telegiornaliste
anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008